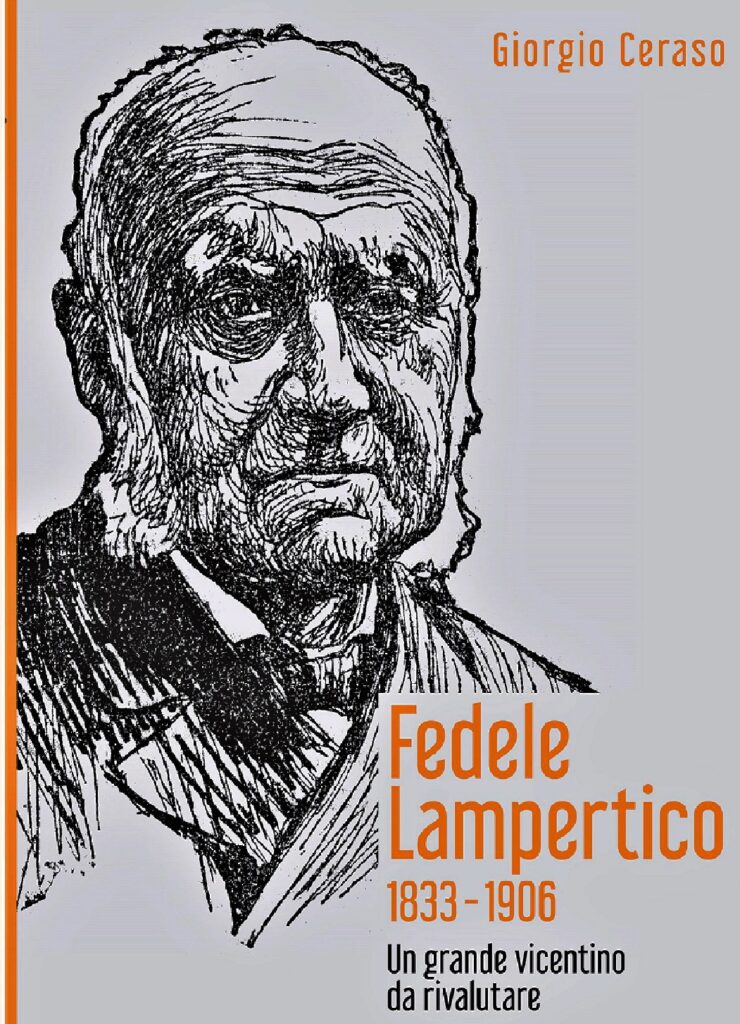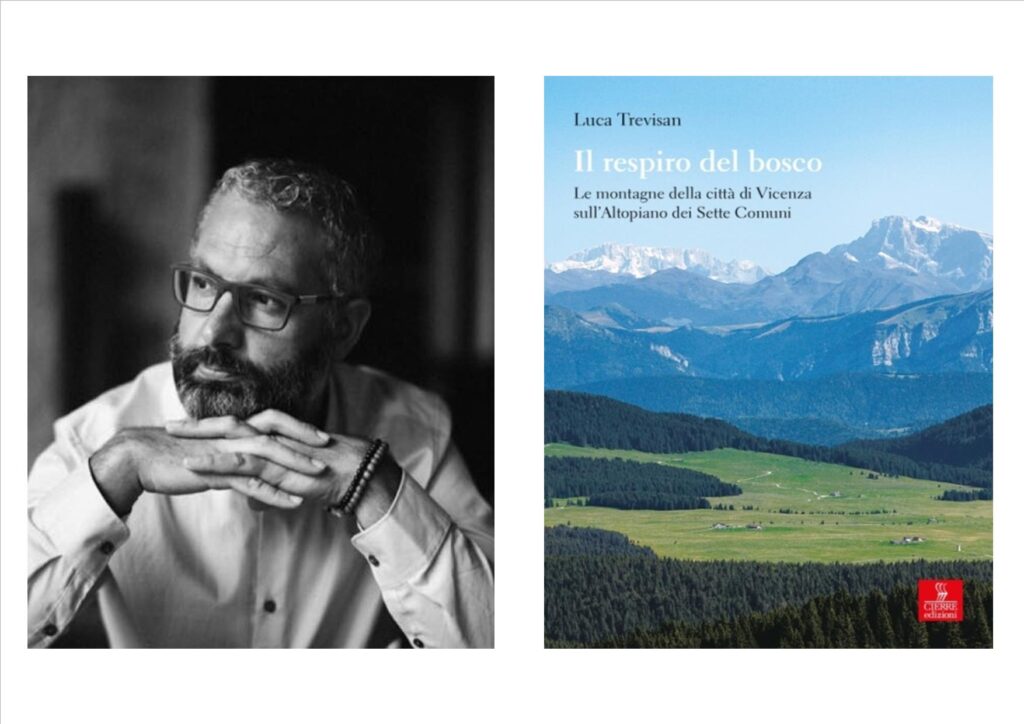INTERVISTA AD AGATA KERAN E A MONS. GASPARINI
IL “SALVATORE TRASFIGURATO” DI GIOVANNI BELLINI. RIFLESSIONI E FONTI PER UNA LETTURA ICONOLOGICA DELL’OPERA
Martedì 30 marzo si è tenuta sulla piattaforma Zoom l’intervista alla dott.ssa Agata Keran e a Mons. Gasparini a cura della docente Katia Brugnolo. Attraverso la presentazione del saggio Il “Salvatore trasfigurato” di Giovanni Bellini. Riflessioni e fonti per una lettura iconologica dell’opera, scritto da Agata Keran e recentemente pubblicato a cura di ZeL Edizioni, i due ospiti hanno delineato il profilo storico e artistico di una Vicenza umanista, spiegandoci inoltre come questo periodo culturale abbia influito sulla genesi del dipinto belliniano. Leggiamo, dunque, l’interessante e didattica chiacchierata avvenuta tra l’intervistatrice Katia Brugnolo (grassetto) e i due oratori, la dott.ssa Agata Keran (stampatello) e Mons. Gasparini (corsivo).
“Chiederei ad Agata Keran di guidare il nostro pubblico alla conoscenza delle importanti presenze e simbologie legate a due mondi importantissimi, il mondo della natura e della teologia, all’interno del dipinto di Giovanni Bellini”
La dott.ssa Agata Keran cerca di tracciare una sintesi di queste simbologie e presenze, partendo dalla scansione in tre registri tematici della composizione: lo sfondo paesaggistico, la scena teofanica e il percorso di salita. Nel primo registro vediamo un importante sfondo paesaggistico, fondamentale per la lettura del dipinto, un surplus dato dal maestro: la scena diventa finalmente un tessuto vivente grazie alla natura e alle presenze architettoniche. Nella tradizione iconografica, la grande importanza è data dal registro centrale, la cui centralità rispecchia perfettamente il momento della trasfigurazione sul Monte Tabor: salito sul Monte Tabor con Giacomo, Pietro e Giovanni, Gesù si trasfigura dinnanzi a due grandi testimoni dell’antico testamento, Mosè ed Elia. La scena è di carattere teofanico perché Cristo si svela nella sua natura divina, prefigurando la luce della resurrezione. Infatti, il bagliore della sua veste calamita l’attenzione in modo quasi ipnotico.
Lo sguardo in contemplazione potrà soffermarsi su questa moltitudine di dettagli allegorici diffusi nella composizione: dalla gestualità dei protagonisti, a molteplici elementi paesaggistici ed allegorici; e soprattutto la staccionata dell’ultimo registro, che in realtà è il primo che noi attraversiamo come osservatori, perché è un invito a salire questa staccionata, di proseguire lungo il colle con la fatica dei nostri passi per salire al Tabor e partecipare attivamente attraverso la preghiera a questo episodio evangelico. In questo caso, la roccia è una roccia parlante, descritta in modo minuzioso, costellata di piante salubri: un vero e proprio repertorio botanico.
L’albero tagliato in primo piano accanto alla figura di San Giacomo ci fa capire quanto è polisemantico un simbolo: allude contemporaneamente sia al futuro sacrificio di Gesù sia al martirio dell’apostolo Giacomo.
“La liturgia delle ore: com’era proposta al tempo di Bellini e com’è, invece, proposta al giorno d’oggi?”
La liturgia delle ore è rimasta con la sua scansione. Forse, all’epoca del Bellini, all’inizio del XVI secolo, il discorso era più preciso perché la vita era meno segnata dal movimento e dalle occupazioni. Quindi, il mattino nella cattedrale cominciava con le messe, l’ufficio delle letture, e soprattutto le lodi, che scandivano la vita quando c’era il sorgere del sole. Al tempo, sorgeva la luce, entrava dai grandi finestroni bianchi dell’abside della cattedrale e si accompagnava al momento dell’Inno al Cristo. Al tramonto, analogamente, quando il sole calava ed inondava di luce la cattedrale, si iniziava la liturgia dei Vespri. La cattedrale di Vicenza, fino alla ricostruzione postbellica, era tutta bianca, non c’era questo finto mattone dipinto; quindi la luce entrava con tutta la sua evidenza ed inondava la cattedrale.
“Passando a considerare la commissione vicentina della pala e i passaggi di proprietà, l’enigma sull’opera s’infittì dopo che Edoardo Aslan nel 1956 intuì che la Trasfigurazione di Bellini andava associata alla cattedrale di Vicenza. L’opera, dal 1613, viene rimossa dalla cattedrale e vive parecchi anni di presenza misteriosa nella collezione Farnese. Inoltre, la possibile commissione della famiglia Fioccardo costituisce un ulteriore percorso di ricerca che Agata Keran sviscera fornendo ipotesi basate su ricerche scientifiche. Quali sono dunque gli elementi oggettivamene certi e provanti e quali incertezze, invece, restano ancora da appurare sulla commissione vicentina della pala di Bellini?”
Quando si entra in cattedrale, la seconda cappella sulla sinistra non ha nulla a che fare con la cappella che ospitava la pala del Bellini. Ancora oggi, questa cappella dei Fioccardo si chiama “della Trasfigurazione” e ospita un dipinto che rappresenta il soggetto iconografico della Trasfigurazione. Alla fine del XV secolo, tuttavia, non c’era l’altare Cinquecentesco ad oggi presente perché quest’ultimo era posizionato sulla controfacciata della cattedrale. C’era una pala rettangolare al suo posto, dettaglio che ci fa dunque pensare ad una cappella totalmente diversa da come la vediamo oggi.
Sicuramente, nella cappella Fioccardo, ci doveva essere una pala del Bellini e, se consideriamo l’ipotesi che la pala fosse proprio quella presente ora a Capodimonte, l’intuizione di Aslan è corretta. Tuttavia, i riscontri documentari non sono calzanti, quindi è un paradigma ipotetico. Lavorando intensamente per quattro anni sulle fonti d’archivio letterarie, la dott.ssa Keran arriva a capire che l’intuizione geniale di Aslan deve mantenere un certo grado di incertezza: è plausibile che la Trasfigurazione di Capodimonte sia stata realizzata per la cattedrale di Vicenza ma non abbiamo nessuna prova certa, anche perché lo stesso Bellini dipinse due opere con lo stesso soggetto.
L’ipotetica committenza vicentina era certamente all’altezza di tale portata, simbolo di una Vicenza dell’epoca umanistica straordinariamente interessante, attraversata non solo da astri nascenti attivi in città, ma anche da molti passaggi che hanno dato un grande apporto alla città.
“La non conoscenza dell’iconografia e dell’iconografia religiosa porta oggi a scambiare la Trasfigurazione con la Resurrezione. Ci racconta quando e come è successo a livello universitario?”
Se si vuole capire ed entrare in profondità in un quadro, bisogna capire l’episodio biblico che rappresenta e, soprattutto, il momento di suddetto episodio che l’autore vuole rappresentare. Per esempio, l’Ultima Cena di Leonardo è un momento che l’autore vuole rappresentare: quando Cristo afferma che qualcuno lo tradirà. L’arte, infatti, dà una sua interpretazione teologica dei fatti biblici narrati, perché l’arte non è soltanto descrizione della Bibbia, ma diventa teologia, interpretazione e prende parte attiva: non si entra nell’anima del quadro se non si capisce l’esatto momento biblico rappresentato. Esiste una povertà delle immagini, oggi, che non c’è da sorprendersi se qualcuno confonde il Cristo trasfigurato con il Cristo risorto. Un altro problema è dato dal fatto che ormai quasi più nessuno si ferma ad osservare il quadro, perché si è troppo impegnati a scattare fotografie con il cellulare. In questo modo, l’immagine non riesce ad entrare nel nostro cuore e raggiungere l’anima.
“Lo studio della figura di Alberto Fioccardo, canonico della cattedrale al momento della realizzazione dell’opera di Bellini, apre un’indagine molto stimolante per la lettura del dipinto belliniano sulle bellezze dell’ambiente naturale che circonda Vicenza. Il progetto iconografico da chi può essere stato formulato per la Trasfigurazione?”
La famiglia Fioccardo era di profilo molto alto. Lo stesso Alberto, arcidiacono della cattedrale, era una persona estremamente inserita in quello che era il tessuto umanistico, e non solo, della città a quel tempo ed era attivo nelle cerchie intellettuali, religiose e laiche di Roma e Padova. Le fonti, Memorie di Barbarano, lo descrivono come una figura illustre, uomo estremamente dotto. Dalle indagini, inoltre, è stata messa a fuoco la figura di Battista, il fratello ed erede di Alberto, che ha portato a compimento il disegno della cappella Fioccardo. Tuttavia, dallo studio di Agata Keran, emergono due figure mai prese in esame ma di notevole importanza: Bono di Battista Fioccardo, dottore in legge, e Bartolomeo di Zambono Ovetari, canonico della cattedrale vicentina. Essi sono menzionati direttamente del testamento di Alberto Fioccardo, due nipoti amatissimi che diventeranno portatori di questa eredità legata all’illustre zio.
Nel momento della realizzazione dell’opera di Bellini, Bartolomeo Ovetari era uno dei canonici della cattedrale, documentato in questo ruolo dal 1477 al 1493. Tale status gli consentiva senz’altro di sorvegliare da vicino i lavori della cappella Fioccardo, favorendo inoltre un eventuale contributo dottrinale nella messa a fuoco del programma iconografico della pala d’altare.
A Vicenza c’erano due centri culturali: uno legato alla cattedrale, il Capitolo della Cattedrale dei canonici, e l’altro era Santa Corona dei Domenicani. Entrambi si contendevano un primato religioso e liturgico, sia per la presenza di reliquie al loro interno che per la loro attività di ospitare importanti processioni. Questi canonici vicentini hanno, quindi, sicuramente aiutato un progetto iconografico: in cattedrale era presente la pala della Trasfigurazione e, pochi anni dopo, Santa Corona ha commissionato allo stesso Bellini una pala con il Battesimo di Cristo. Bisogna ricordare che nel 1404 Vicenza era entrata nella Serenissima Repubblica di Venezia, con conseguente arrivo di una forte ondata culturale.
“In copertina del volume c’è un ingrandimento del dipinto di Bellini che mostra due figure, un ebreo e un maomettano, dando occasione all’autrice di ricordare un’odiosa vicenda storica: la cacciata degli ebrei dalla città. Chiederei quindi un breve passaggio su questo punto importante.”
L’importante è quando questi capolavori riescono a raccontare un mondo intero, perché diventano un luogo dove si svela sensibilità di un’epoca, i pensieri, le preoccupazioni; un mondo di fatti luminosi e aspetti oscuri, perché quest’opera conserva anche un punto nero che ha segnato in modo profondo il cammino storico di questa comunità di Vicenza.
Nella copertina vediamo l’interesse per il mondo ebraico ma anche la presenza di un maomettano e di un ebreo, che evidenzia pregiudizi, idiosincrasie, paure e timori dell’epoca. Per capire cosa succede in quel momento, bisogna evidenziare una mostra realizzata recentemente al Museo Diocesano Tridentino: ha raccontato in modo approfondito la temperie antiebraica attraverso un caso trentino di un fanciullo piccolissimo, Simonino di Trento, per la cui l’uccisione è stata calunniata la comunità ebraica di Trento. Lo stesso analogo caso è successo anche nel vicentino: la città di Vicenza, nel 1486, arriverà ad un pogrom nei confronti degli ebrei residenti nel territorio vicentino, con il pretesto di un assassinio rituale accaduto in Val Rovina. Il libro della dott.ssa Keran vuole quindi fornire una valida bibliografia per questi temi presenti nel dipinto, il quale apre una narrazione polifonica e una serie di considerazione su molti temi, anche diversi fra di loro.
Tuttavia, la presenza dell’ebreo errante e del maomettano non può essere accusata di questa ferocia, ma è da considerarsi semplicemente come una coppia polare: l’ebreo si oppone all’opulenza del turco.
Su queste due piccole figure, si apre un mondo difficile da capire in una piccola città come Vicenza, che si configura all’interno della Repubblica Veneta come una città in cui le regole contro gli ebrei sono più rigide e numerose. Infatti, dalla cacciata degli ebrei del 1486, Vicenza non avrà più nessuna comunità ebraica presente in città, come invece continua ad esserci in tutte le altre città del Veneto.
“Le iscrizioni ebraiche nel dipinto richiamano il tema del dialogo interreligioso e chiamano intellettuali dell’epoca molto importanti, quali Ermolao Barbaro, Piero Leoni e Nicola Cusano, che sostengono il dialogo interreligioso in contrasto con la temperie antisemita vicentina.”
Bellini è sempre stato sensibile in questo senso, ma bisogna anche considerare la committenza e il periodo storico e culturale di Vicenza a quell’epoca, subito dopo la cacciata degli ebrei dalla città. Siamo in un momento di grande fermento che si vive anche nella cattedrale: da un lato c’è il canonico, Alessandro Nievo, e dall’altro c’è la famiglia Fioccardo. Quindi, se quest’opera è stata realizzata per Vicenza, vuol dire che c’è stata una tensione, un movimento e una disquisizione attorno a una polemica pubblica circa quest’odio antisemita.
Oltre alle iscrizioni, ci sono anche altri dettagli che si vedono sullo sfondo: nel paesaggio troviamo delle pietre diroccate che sono un’allusione al sepolcreto ebraico, quindi l’elemento ebraico è molto presente. Questo interesse per la cultura ebraica è una breccia molto coinvolgente: la stessa autrice ha proseguito lungo questa linea per arrivare a seguire le orme del Beato Ambrogio Traversali, presente nella filigrana di questa narrazione. Egli è l’iniziatore di questa attenzione nei confronti del dialogo interreligioso ed è una figura fondamentale per l’Umanesimo italiano: vuole tornare alle radici, non solo desidera acquisire i testi della parola greca, ma comincia a coinvolgere i madre lingua che parlano in ebraico – cosa fondamentale per le iscrizioni presenti in questo dipinto.
Nella palla belliniana troviamo Mosè in abito rosso e il profeta Elia. Il primo personaggio tiene fra le mani un cartiglio in cui è riportata la data ebraica “5239”, che equivale al periodo a cavallo tra l’anno 1478 e 1479. È un anno calendariale ebraico che inizia sempre in autunno e, in questo senso, è interessante metterlo a confronto con il paesaggio del dipinto: le specie botaniche che possiamo osservare, come il ciclamino, diventano un indicatore di stagione. La scritta presente sul cartiglio suggerisce il nome di Menahem, che il paleografo indica come la firma dell’autore delle iscrizioni del quadro e lo associa a un maestro madrelingua coinvolto per l’occasione. Per quanto riguarda l’interpretazione della scritta, la dott.ssa concorda con Saracino nello stabilire “Consolatore” come significato ebraico della parola Menahem; mentre l’abbreviazione ebraica “br” potrebbe significare “figlio” in aramaico. Quindi, l’iscrizione si potrebbe tradurre con “Consolatore figlio di Dio”.
A questo proposito bisogna ricordare il passo di San Paolo riferito al Consolatore Gesù: qui si nota la molteplicità della parola “consolazione”, che viene ribadita più volte ed entra nel cuore della preghiera.
La presenza di testi ebraici nei dipinti quattrocenteschi è molto diffusa e qui si vede chiaramente come ci sia un emergere, nel Rinascimento, del mondo ebraico. Questo vuol dire che c’era un dialogo tra il mondo dotto cristiano-occidentale e il mondo dotto degli ebrei. Gli artisti che hanno inserito l’ebraico nelle loro opere sono, specialmente, quelli operanti nell’area veneta ed emiliana. Tuttavia, tutti i rinascimentali sono autori che nella loro competenza hanno latino, greco ed anche ebraico: non sono anticristiani ma vogliono tornare alle radici della fede cristiana, valutando anche le radici ebraiche del cristianesimo.
Noemi Zaupa